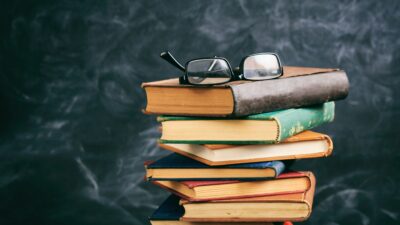Che cos’è davvero un trend? Un hashtag virale? Un’estetica che dilaga su TikTok? Una moodboard da Pinterest? O forse è qualcosa di più sottile, che inizia a vibrare nel modo in cui le persone parlano, sentono, abitano le città, consumano e si emozionano?
Per Giulia Maria Moschen Bracho, trend researcher e docente di consumer behaviour con base a Barcellona, i trend sono prima di tutto movimenti culturali e sentimentali. Sono piccole onde emotive che attraversano le persone prima ancora che i mercati. Sono segnali deboli che crescono tra le pieghe del quotidiano, e che vanno ascoltati prima che diventino buzzword.
Il suo percorso inizia nel mondo del retail, dove per anni ha analizzato i feedback dei clienti per tradurli in esperienze migliori, progetti omnichannel e strategie commerciali. Ma a un certo punto, quando il fast-fashion ha iniziato a brillare più di greenwashing che di reale trasformazione, Giulia ha deciso che era ora di cambiare binario. Non ha lasciato il mondo dei consumi- lo ha solo guardato da un altro punto di vista: più umano, più critico, più profondo.
Oggi lavora come trend researcher e consulente freelance, collaborando con aziende e agenzie tra interior design, wellness, lifestyle e ospitalità. Insegna al CETT – Università di Turismo e Hospitality di Barcellona, scrive per riviste italiane e internazionali su megatendenze, corpi del futuro, design e rappresentazione. Ma soprattutto osserva con attenzione come i sentimenti delle persone si intrecciano con il cambiamento.
Barcellona, con le sue luci, le sue contraddizioni, la sua densità urbana e culturale, è il suo osservatorio ideale: una città-laboratorio, dove le trasformazioni sociali si manifestano in modi piccoli ma chiarissimi. Una città da cui partono segnali che spesso anticipano, amplificano o reinterpretano movimenti globali.
Con uno sguardo allenato tra rigore e sensibilità, Giulia si muove tra ricerca qualitativa e foresight, mettendo al centro le persone, i contesti, le emozioni. Noi di The Buns l’abbiamo intervistata per parlare di trend, città, futuri possibili, e di quel sentimento collettivo che attraversa il presente e, in qualche modo, ci dice già dove stiamo andando.
*
Benvenuta a Buns! Andiamo subito al sodo. Hai iniziato nel retail, sei passata al lifestyle, all’interior design e ora insegni anche in un’università dedicata all’ospitalità. Se guardi il tuo percorso, sembra una mappa che si disegna seguendo i movimenti delle persone. Ti ci ritrovi? E cosa ti porti dietro da quel primo capitolo nel commercio, che magari non ti aspettavi ti tornasse utile oggi?
Se mi volto indietro, mi rendo conto che esiste un filo conduttore, seppur invisibile, che collega molte delle esperienze professionali che ho intrapreso, ben prima che comparisse sul mio curriculum la dicitura “Trend e Cultural Researcher”. La curiosità è sempre stata una costante, ma il mio primo incontro consapevole con la ricerca è avvenuto durante lo stage del mio master, a New York City, presso il Museo del Barrio, specializzato in arte latino-americana.
In quell’occasione, il direttore del dipartimento educativo mi invitò a proporre nuove idee per i programmi culturali. Per farlo, iniziai una vera e propria ricerca sul campo: visitai diversi musei della città, partecipando ad attività educative, laboratori e visite guidate, osservando con attenzione il comportamento dei visitatori e intervistando sia il pubblico sia il personale museale. Quel tipo di ricerca, condotta direttamente sul campo e in contatto diretto con le persone, è stato per me una rivelazione. Capire come le persone si muovono, cosa si aspettano, quali sono le loro motivazioni, e farlo all’interno del contesto reale, mi è sembrato da subito uno degli strumenti più potenti per comprendere la cultura contemporanea.
La mappa del mio percorso professionale affonda le sue radici proprio in questa dimensione: l’analisi culturale. Ogni tappa è stata guidata dal desiderio di capire perché certi fenomeni emergono in un dato momento storico, e cosa questi cambiamenti possano raccontarci delle persone e del loro immaginario.
Cosa mi porto dietro dal mio primo capitolo nel commercio? È stato un periodo estremamente formativo, sotto molteplici aspetti. All’epoca non conoscevo ancora il concetto di systems thinking, ma lavorare a stretto contatto con diversi reparti, comprendere la complessità delle interdipendenze e valutare le possibili conseguenze di ogni decisione, ha contribuito in modo significativo a plasmare il mio approccio sistemico e strategico al lavoro che oggi svolgo.
Vivere e lavorare a Barcellona ti mette a contatto con una città piena di tensioni ma anche di energie nuove. Quali sono i segnali – magari piccoli, quasi invisibili – che oggi ti stanno raccontando qualcosa sul nostro futuro collettivo?
Siamo in un periodo storico estremamente complesso, in cui i cambiamenti si susseguono a un ritmo sempre più accelerato. Barcellona è una città che ha vissuto trasformazioni significative in un arco di tempo relativamente breve, e dove quella che per anni è stata una delle sue principali forze, la capacità di attrarre un turismo internazionale molto intenso, si sta rivelando anche una delle sue principali fonti di tensione.
A questo si aggiunge la pressione crescente esercitata dalla crisi climatica: temperature costantemente sopra la media, ondate di calore sempre più lunghe e ravvicinate, siccità endemica. Tutto questo mette a dura prova la vivibilità quotidiana, soprattutto per chi abita la città in maniera stabile.
Eppure, proprio in questa tensione, si generano segnali interessanti. Li vedo nei piccoli tentativi di riorganizzazione dal basso: spazi comunitari che nascono nei quartieri, nuove forme di mutualismo urbano, una crescente attenzione al concetto di cura – inteso non solo come benessere individuale, ma come responsabilità collettiva.
Mi colpisce anche come molte iniziative culturali stiano provando a riscrivere le narrazioni dominanti sulla città, cercando di costruire immaginari alternativi, più sostenibili e più inclusivi. Sono segnali magari fragili, ma fortemente significativi, perché ci parlano di una città che, pur sotto pressione, non smette di immaginare il futuro e di provare a costruirlo, collettivamente.
La tua esperienza tra Italia e Spagna ti dà uno sguardo prezioso su due culture vicine ma diverse. Cosa vedi quando guardi l’Italia da fuori? Cosa ti manca, cosa ti sorprende, cosa invece ti fa pensare che dobbiamo ancora fare un bel pezzo di strada?
Vedo l’Italia come un Paese dal potenziale immenso, riconosciuto a livello internazionale per l’eccellenza in settori come il design, la moda, l’enogastronomia. Quello che mi manca di più è il senso estetico, direi quasi istintivo, che ci attraversa a ogni livello. Anche nelle cose più semplici, come un caffè al bar, c’è un’attenzione al dettaglio che lo trasforma in un piccolo rito, una micro-esperienza sensoriale e visiva.
Quello che mi colpisce, osservandola da fuori, è che spesso questo patrimonio culturale così ricco e profondo, che potrebbe essere una leva di innovazione incredibile, diventa invece una zavorra. La nostra storia è una forza, ma a volte ci impedisce di muoverci con agilità. Fatichiamo ad abbracciare il cambiamento, a reimmaginare le nostre strutture, a lasciar andare certe rigidità.
C’è creatività, competenza e visione, ma manca, troppo spesso, il coraggio sistemico di rinnovarsi. È lì che sento che c’è ancora molta strada da fare.
Hai scritto di transumanesimo, di come i nostri corpi stanno cambiando, di come li abiteremo domani. Ti va di raccontarci cosa ti affascina di più in questo discorso? È un tema che senti più legato alla tecnologia o all’identità?
Che bello che tu menzioni l’articolo che ho scritto quattro anni fa! È un tema ancora più attuale oggi, soprattutto con l’avvento dell’intelligenza artificiale. Nel testo originale scrivevo: “La transumanità e il futuro dei nostri corpi (e delle nostre coscienze?)”. È una domanda che, oggi più che mai, risuona in un mondo radicalmente trasformato dall’uso di tecnologie come ChatGPT, che sta davvero rivoluzionando l’interazione uomo-macchina nella nostra vita quotidiana.
Questo discorso mi affascina perché la tecnologia ci apre a nuove dimensioni, ma allo stesso tempo ci spinge a rivedere altre. Cambia chi siamo, come ci comportiamo, e, soprattutto, come vediamo il mondo. È, quindi, un tema fortemente legato alla nostra identità e a come le tecnologie possano trasformarla. La sovrapposizione tra l’essere umano e la macchina è inevitabile, e questa fusione avrà implicazioni profonde su come pensiamo, sentiamo e agiamo.
Non credo che dobbiamo temere questo cambiamento, piuttosto dobbiamo imparare a capirlo, a gestirlo e, soprattutto, a regolamentarlo. La nostra relazione con la tecnologia è destinata a ridefinire non solo i nostri corpi, ma anche la nostra mente, il nostro cervello, come sta già accadendo con l’intelligenza artificiale e il suo impatto sulle capacità cognitive e sul pensiero umano.
Cosa significa, per te, che una tendenza è vera? Quando senti che non è solo una moda passeggera, ma qualcosa che vale la pena esplorare a fondo?
Il termine “tendenza” è qualcosa che uso sempre meno, perché il suo significato cambia a seconda del contesto e della figura professionale che lo utilizza. Parliamo di una tendenza statistica o di un fenomeno virale nato su TikTok? In generale, possiamo dire che una tendenza rappresenta il complesso di motivi ed orientamenti che sostengo e creano un cambio, generando un’inclinazione negli stili di vita e nei gusti, e che si manifesta trasversalmente in diversi settori.
Le tendenze “vere”, preferisco chiamarle shift, cambiamenti più profondi. Non sono semplici manifestazioni di preferenze, ma veri e propri punti di svolta nel comportamento della società. Considero che vale la pena esplorali perchè osservo delle tensioni: comportamenti opposti che emergono nella società e che poi generano trasformazioni nei nostri stili di vita, nei valori, nelle routine quotidiane e nelle politiche.
Questi shifts non si manifestano mai in modo istantaneo; spesso arrivano lentamente, ma il loro impatto è profondo e duraturo. Sono quei cambiamenti che, pur inizialmente difficili da cogliere, in retrospettiva appaiono come eventi fondamentali che modellano la nostra cultura e le nostre società per decenni. Quando vedo queste dinamiche in atto, capisco che non si tratta solo di una moda passeggera, ma di una forza che vale la pena esplorare con attenzione.
E infine… Se potessi progettare una “ricerca ideale” senza limiti di budget né di tempo – una di quelle da sogno – su cosa la faresti? Dove andresti, chi intervisteresti, cosa vorresti davvero capire sul mondo in cui viviamo?
Che bella questa domanda! Sogno spesso a occhi aperti la mia “ricerca ideale”, e la condurrei sul futuro delle città viste dalla prospettiva dei bambini. Le città sono laboratori di innovazione, spazi affascinanti ma pieni di sfide da superare affinché diventino davvero vivibili per tutti. Oggi molte amministrazioni stanno sperimentando processi di partecipazione attiva nella progettazione urbana. Un esempio recente è Parigi, che ha coinvolto i cittadini – compresi i giovani dai 16 anni in su – per decidere di rendere pedonali circa 500 strade.
Nonostanze consideri questi progretti fondamentali ed all’avanguardia, spesso mi fermo a riflettere su un paradosso: il futuro delle città viene progettato da adulti che non vivranno pienamente nel domani che stanno disegnando. Eppure, i bambini – se coinvolti nel modo giusto, rispettando il loro livello di maturità – possono offrire prospettive sorprendenti, sfuggendo alla rigidità del pensiero adulto.
Nella mia ricerca da sogno intervisterei bambini dai 5 ai 12 anni e i loro genitori, ponendo domande semplici ma profonde: Quali difficoltà incontrano ogni giorno nel loro vivere la città? Come vanno a scuola e come vorrebbero andarci? Come trascorrono il tempo libero e cosa farebbero se potessero scegliere liberamente? Come immaginano il loro futuro nella “giungla urbana” e cosa cambierebbero? In quali momenti del loro quotidianno si sentono felici?
Per andare oltre le risposte razionali, organizzerei un workshop basato su metodologie di futuro, aiutandoli a immaginare e progettare la città dei loro sogni. Questo percorso potrebbe diventare parte di un programma scolastico annuale, offrendo ai bambini la possibilità di sviluppare il pensiero anticipante e migliorare la loro future literacy, una competenza fondamentale per affrontare le sfide di domani.
Mi chiedi cosa vorrei capire sul mondo in cui viviamo con questa ricerca. Forse, più che capire, vorrei imparare a vedere con occhi nuovi, liberandomi dai preconcetti che i bambini non hanno. Una skill importante per chi si occupa di ricerca! Il loro modo di ragionare è spesso spiazzante perché non è ancora incasellato in schemi rigidi: vedono possibilità dove gli adulti vedono limiti, trasformano problemi in giochi e sognano città che noi fatichiamo anche solo a immaginare. Per costruire un domani diverso dall’oggi dobbiamo lasciare andare i paradigmi con i quali guardiamo il mondo e vedere tutto con gli occhi nuovi dei bambini.
Forse il segreto per costruire un futuro migliore non è solo progettare per loro, ma con loro.