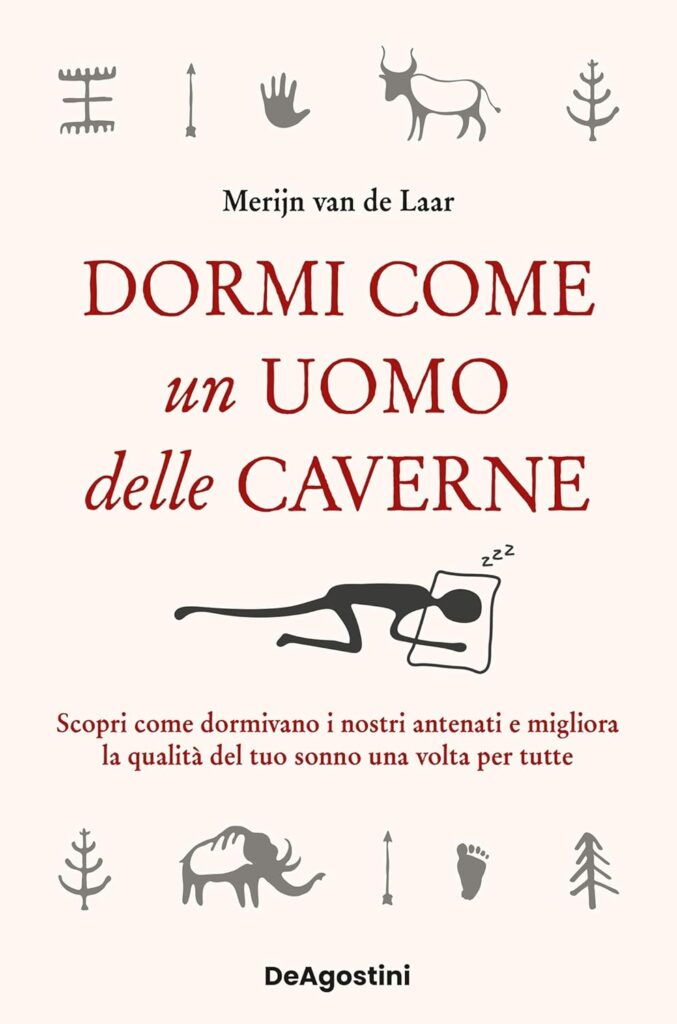Dormire non è solo il sogno proibito dei neogenitori. È diventato un atto di resistenza, un privilegio sociale, una nuova moneta del benessere. In Italia, dove si lavora più ore della media europea e dove il culto della produttività è ancora profondamente radicato, il sonno viene spesso sacrificato in silenzio. Nonostante le evidenze scientifiche, riposare a sufficienza non è ancora percepito come un diritto, ma come una concessione. Una debolezza, persino.
Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, quasi un terzo degli italiani soffre di disturbi del sonno. Ma la mancanza di sonno non è distribuita in modo equo. A perderlo sono soprattutto le persone con lavori precari, chi gestisce carichi di cura importanti, chi vive condizioni di salute mentale o fisica croniche. Come scrive il neuroscienziato Matthew Walker sul The Guardian, “nessun aspetto della nostra biologia è risparmiato dalla privazione di sonno”. Eppure, più il sonno diventa scarso, più aumenta il suo valore percepito. In un paradosso ormai evidente, il dormire si sta trasformando in un nuovo simbolo di status: chi può permetterselo, lo ottimizza; chi non può, lo rincorre.
Nasce così un nuovo mercato del sonno: materassi hi-tech che regolano temperatura e respirazione, coperte ponderate per calmare il sistema nervoso, wearable per tracciare ogni fase del riposo, app di meditazione con voci suadenti e abbonamenti premium. Anche in Italia, brand e influencer cavalcano l’onda: dai “mocktail della sonnolenza” a base di magnesio e melatonina, ai retreat per il sonno immersi nella natura, fino al boom dell’estetica “bedcore”, dove il pigiama in lino lavato diventa un’affermazione di lifestyle.
Intanto su TikTok, mentre milioni di video contribuiscono alla nostra insonnia, si moltiplicano i contenuti dedicati al “sleepmaxxing”: hack, routine, prodotti e rituali per dormire meglio. Dormire è diventato cool, aspirazionale, performativo. Ma rendere il sonno un oggetto del desiderio ci aiuta davvero a ricordarci quanto è importante? O rischia di trasformarlo in un altro indicatore di disuguaglianza, disponibile solo per chi ha tempo, spazio e denaro?
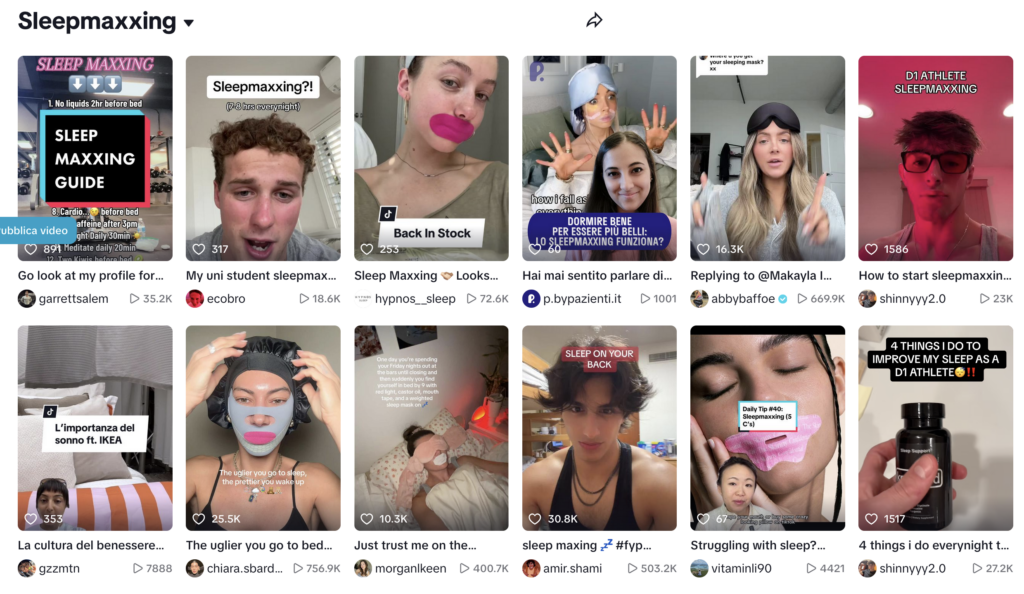
Dormire è diventato desiderabile, affascinante, cool. E soprattutto, è diventato un simbolo di status. Avere il tempo, e le risorse, per dormire bene e a lungo è oggi un segnale di privilegio. Non è più solo questione di sopravvivere alle giornate con cinque ore di sonno: oggi, otto ore sono solo il punto di partenza. Chi può, le potenzia.
Il mercato del wellness lo sa bene: il buon sonno è il nuovo oro. Melatonina, CBD, magnesio in polvere, oli essenziali e coperte ponderate promettono sogni migliori. Le lenzuola sono smart. Il materasso è connesso. Le spa diventano “sleep retreat” immersi nel silenzio. Anche la moda, da sempre iperstimolante, partecipa a questo immaginario: JW Anderson crea felpe con slogan come REAL SLEEP, Rick Owens disegna capsule in collaborazione con Moncler ispirate al concetto di bozzolo. Intanto, il bedcore sostituisce lo streetwear: si sfoggia la coperta, non la borsa.
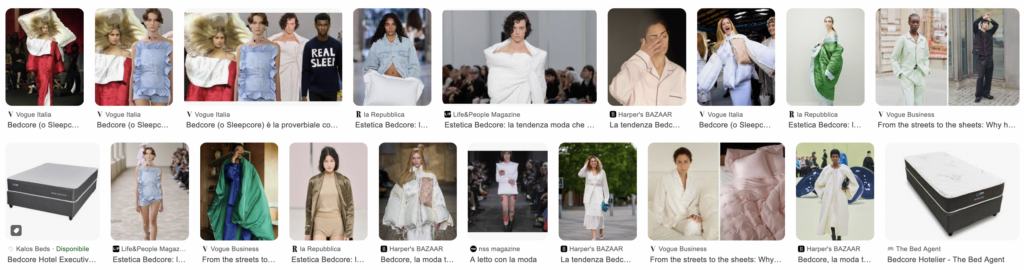
Ma la verità è che dormire bene resta un sogno irrealizzabile per moltissime persone. La fatica cronica è aumentata, soprattutto dopo la pandemia, con un picco di burnout tra i lavoratori del settore pubblico e in generale un’esplosione di stress che ha compromesso la qualità del sonno di milioni di persone. Il problema è che nel frattempo alimentiamo da soli la nostra insonnia. Viviamo in un mondo che ci tiene sempre accesi. Sempre reperibili, sempre connessi.
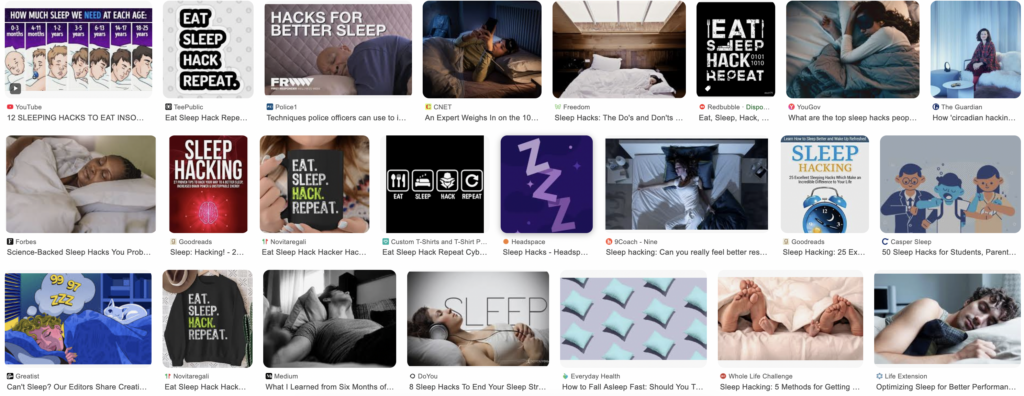
In parallelo cresce la povertà di tempo: riuscire a dormire diventa una sfida logistica, soprattutto per chi vive con figli, per chi lavora su turni o ha carichi di cura. Secondo recenti rilevazioni, chi convive con bambini sotto i 15 anni ha fino a 14 ore di tempo libero in meno ogni settimana. E così la notte si fa giorno, e il riposo si spezzetta, si sposta, si comprime. Trovare lo spazio per dormire otto ore – di quelle vere, continue, rigeneranti – è oggi un segno di efficienza, di organizzazione, ma anche di privilegio economico. Forse, in fondo, dormire è il nuovo mangiare fuori: una forma di lusso accessibile a pochi, un’esperienza da prenotare in anticipo, da meritare, da pagare.
In fondo, oggi il lusso non si misura più (solo) in metri quadrati o in carati. Non è necessariamente appariscente, né deve gridare la sua presenza. Dopo l’ondata del quiet luxury – e in un contesto in cui il potere d’acquisto è calato per molti – stiamo assistendo a una trasformazione silenziosa ma profonda: il nuovo lusso è discreto, accessibile, spesso mentale. Mentre il mercato dell’auto rallenta e i gioielli perdono attrattiva, piccoli oggetti come occhiali da sole, cinture e accessori diventano segnali sottili di distinzione.
Anche il sonno segue questa logica. Certo, ci sono materassi di ultima generazione che costano come un weekend a Tokyo – l’ultima versione dell’Eight Sleep supera i 4.000 euro – ma il nuovo sleep luxury ha molte porte d’ingresso. Bastano 30 euro per una confezione di integratori al magnesio, 20 per una mascherina in seta o un profumo per cuscini alla lavanda. Spese contenute, ma percepite come cura, come investimento sul proprio benessere.
Il bello è che il mercato del sonno promette qualcosa che pochi altri settori possono offrire: l’illusione (o forse la speranza concreta) della durata. Siamo ossessionati dall’ottimizzazione. Il suffisso “-maxxing” è diventato un mantra digitale: looksmaxxing, statusmaxxing… ora anche sleepmaxxing. L’idea che ogni aspetto della vita possa e debba essere portato al massimo livello è penetrata anche nel mondo del riposo. Dormire bene non è più abbastanza. Bisogna dormire meglio. Dormire strategicamente. Dormire per performare.
Siamo sempre più consapevoli dell’impatto che il sonno ha sulla salute mentale, sul metabolismo, sull’umore, sulla concentrazione. E così cerchiamo di addomesticarlo, di dominarlo, di ottimizzarlo, come se fosse una skill. Dormire diventa un modo per essere più produttivi da svegli, o per sfuggire – almeno temporaneamente – al potere invasivo del lavoro sulla nostra psiche e sul nostro tempo. Ma c’è qualcosa di profondamente ironico in tutto questo: ci affanniamo a controllare, tracciare, progettare l’atto più inconscio che esista.
La sleep anxiety, l’ansia legata al non riuscire ad addormentarsi, è oggi riconosciuta come una componente chiave dell’insonnia moderna. Eppure, mentre da un lato il sonno viene celebrato come un bene prezioso, dall’altro c’è ancora chi lo disprezza, lo svaluta. E così, rischiamo di tornare a un’idea tossica: dormire è per i deboli. È per chi può permetterselo. È tempo perso. In un contesto così polarizzato, alcuni iniziano a mettere in discussione anche la regola aurea delle otto ore. La terapeuta del sonno Merin van de Laar, nel suo libro How to sleep like a caveman – in Italia Dormi come un uomo delle caverne: Scopri come dormivano i nostri antenati e migliora la qualità del tuo sonno una volta per tutte – propone un modello alternativo: dormire a fasi, svegliarsi durante la notte, normalizzare l’imperfezione. Forse il futuro del sonno non sarà fatto di rituali sereni, ma di un ritorno istintivo e intermittente, un sleep hacking più grezzo e primordiale.
Una caverna, più che una spa.